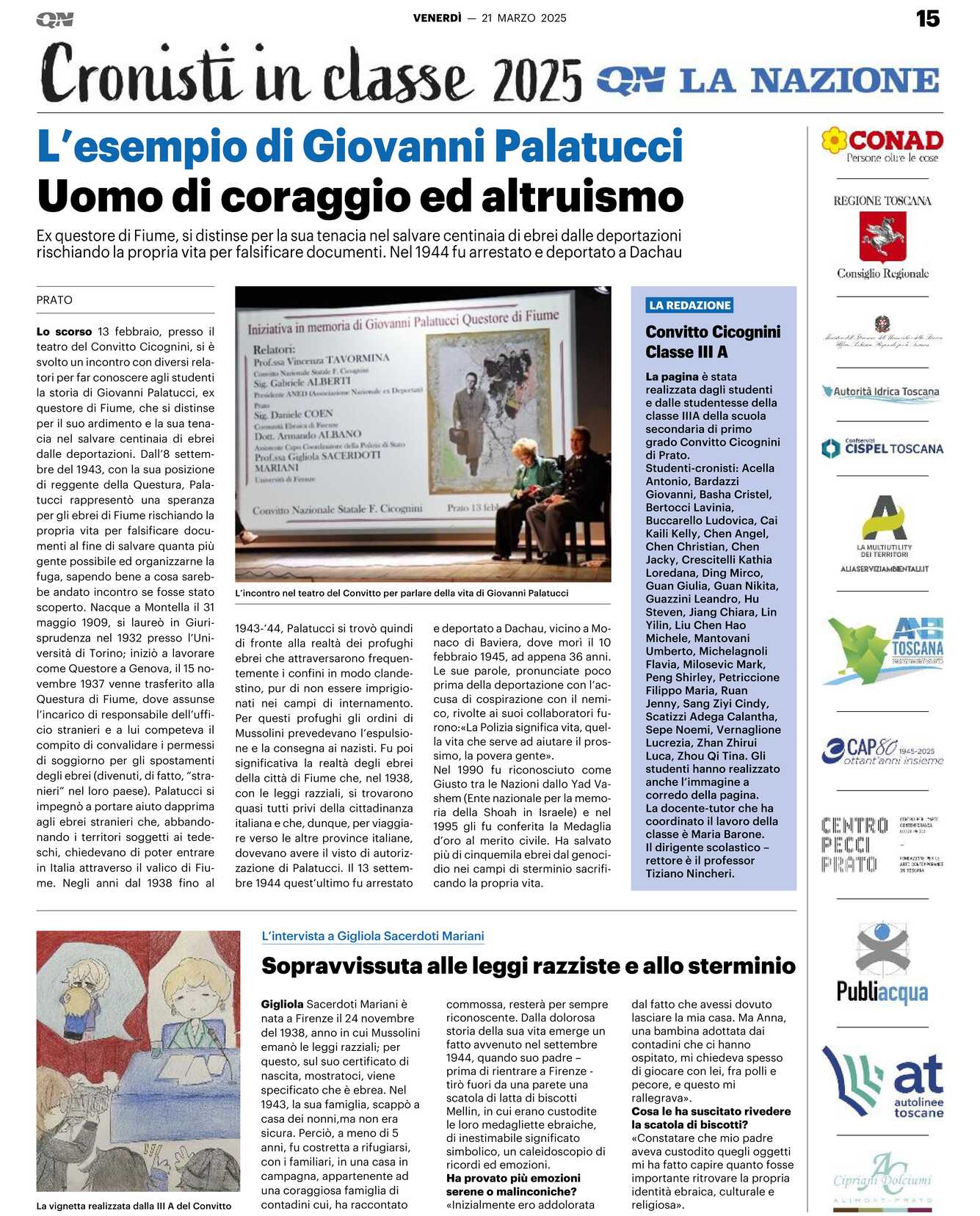L’esempio di Giovanni Palatucci Uomo di coraggio ed altruismo
Ex questore di Fiume, si distinse per la sua tenacia nel salvare centinaia di ebrei dalle deportazioni rischiando la propria vita per falsificare documenti. Nel 1944 fu arrestato e deportato a Dachau

Lo scorso 13 febbraio, presso il teatro del Convitto Cicognini, si è svolto un incontro con diversi relatori per far conoscere agli studenti la storia di Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume, che si distinse per il suo ardimento e la sua tenacia nel salvare centinaia di ebrei dalle deportazioni. Dall’8 settembre del 1943, con la sua posizione di reggente della Questura, Palatucci rappresentò una speranza per gli ebrei di Fiume rischiando la propria vita per falsificare documenti al fine di salvare quanta più gente possibile ed organizzarne la fuga, sapendo bene a cosa sarebbe andato incontro se fosse stato scoperto. Nacque a Montella il 31 maggio 1909, si laureò in Giurisprudenza nel 1932 presso l’Università di Torino; iniziò a lavorare come Questore a Genova, il 15 novembre 1937 venne trasferito alla Questura di Fiume, dove assunse l’incarico di responsabile dell’ufficio stranieri e a lui competeva il compito di convalidare i permessi di soggiorno per gli spostamenti degli ebrei (divenuti, di fatto, “stranieri” nel loro paese). Palatucci si impegnò a portare aiuto dapprima agli ebrei stranieri che, abbandonando i territori soggetti ai tedeschi, chiedevano di poter entrare in Italia attraverso il valico di Fiume. Negli anni dal 1938 fino al1943-‘44, Palatucci si trovò quindi di fronte alla realtà dei profughi ebrei che attraversarono frequentemente i confini in modo clandestino, pur di non essere imprigionati nei campi di internamento.
Per questi profughi gli ordini di Mussolini prevedevano l’espulsione e la consegna ai nazisti. Fu poi significativa la realtà degli ebrei della città di Fiume che, nel 1938, con le leggi razziali, si trovarono quasi tutti privi della cittadinanza italiana e che, dunque, per viaggiare verso le altre province italiane, dovevano avere il visto di autorizzazione di Palatucci. Il 13 settembre 1944 quest’ultimo fu arrestato e deportato a Dachau, vicino a Monaco di Baviera, dove morì il 10 febbraio 1945, ad appena 36 anni.
Le sue parole, pronunciate poco prima della deportazione con l’accusa di cospirazione con il nemico, rivolte ai suoi collaboratori furono: «La Polizia significa vita, quella vita che serve ad aiutare il prossimo, la povera gente».
Nel 1990 fu riconosciuto come Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem (Ente nazionale per la memoria della Shoah in Israele) e nel 1995 gli fu conferita la Medaglia d’oro al merito civile. Ha salvato più di cinquemila ebrei dal genocidio nei campi di sterminio sacrificando la propria vita.
Gigliola Sacerdoti Mariani è nata a Firenze il 24 novembre del 1938, anno in cui Mussolini emanò le leggi razziali; per questo, sul suo certificato di nascita, mostratoci, viene specificato che è ebrea. Nel 1943, la sua famiglia, scappò a casa dei nonni, ma non era sicura. Perciò, a meno di 5 anni, fu costretta a rifugiarsi, con i familiari, in una casa in campagna, appartenente ad una coraggiosa famiglia di contadini cui, ha raccontato commossa, resterà per sempre riconoscente. Dalla dolorosa storia della sua vita emerge un fatto avvenuto nel settembre 1944, quando suo padre – prima di rientrare a Firenze tirò fuori da una parete una scatola di latta di biscotti Mellin, in cui erano custodite le loro medagliette ebraiche, di inestimabile significato simbolico, un caleidoscopio di ricordi ed emozioni.
Ha provato più emozioni serene o malinconiche? «Inizialmente ero addolorata dal fatto che avessi dovuto lasciare la mia casa. Ma Anna, una bambina adottata dai contadini che ci hanno ospitato, mi chiedeva spesso di giocare con lei, fra polli e pecore, e questo mi rallegrava».
Cosa le ha suscitato rivedere la scatola di biscotti? «Constatare che mio padre aveva custodito quegli oggetti mi ha fatto capire quanto fosse importante ritrovare la propria identità ebraica, culturale e religiosa».
La pagina è stata realizzata dagli studenti e dalle studentesse della classe IIIA della scuola secondaria di primo grado Convitto Cicognini di Prato.
Studenti-cronisti: Acella Antonio, Bardazzi Giovanni, Basha Cristel, Bertocci Lavinia, Buccarello Ludovica, Cai Kaili Kelly, Chen Angel, Chen Christian, Chen Jacky, Crescitelli Kathia Loredana, Ding Mirco, Guan Giulia, Guan Nikita, Guazzini Leandro, Hu Steven, Jiang Chiara, Lin Yilin, Liu Chen Hao Michele, Mantovani Umberto, Michelagnoli Flavia, Milosevic Mark, Peng Shirley, Petriccione Filippo Maria, Ruan Jenny, Sang Ziyi Cindy, Scatizzi Adega Calantha, Sepe Noemi, Vernaglione Lucrezia, Zhan Zhirui Luca, Zhou Qi Tina. Gli studenti hanno realizzato anche l’immagine a corredo della pagina.
La docente-tutor che ha coordinato il lavoro della classe è Maria Barone.
Il dirigente scolastico – rettore è il professor Tiziano Nincheri.